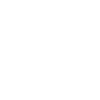Il dolore che traspare per mezzo di una memoria che, come cestello silenzioso di rimembranze e celate menzogne, riluce, attivando quel meccanismo di freudiana prospettiva che va sotto il nome di rimozione, la quale, violenta la dimensione infantile ed inconsapevole di un sogno recondito e spaventoso, fagocitando l’individuo in un contenuto manifesto da dimenticare, cancellare. Così, attraverso il controverso romanzo: “L’ombra affamata della madre” (A.G.A.R. Editrice, pp. 136), si conclude la trilogia della scrittrice e poetessa Maria Teresa Liuzzo, un viaggio nel vasto panorama dei sentimenti umani quello iniziato con: “…E adesso parlo!”, seguito da: “Non dirmi che ho amato il vento”, trasportando, saggiamente e sagacemente, il lettore in un’oasi in cui l’arte della parola luce in un universo costruito con ciò che lo scrittore Pierpaolo Pasolini definirebbe “violenta passione”, un amore travolgente che sottomette ogni regola di razionalità e lapalissiana consapevolezza. La storia di Mary, la dolce fanciulla preda di intrighi familiari e costanti labirinti di beffarde falsità, si arricchisce di un nuovo capitolo costellato di dolci illusioni e travestimenti ad opera non soltanto di quella madre che, come natura matrigna di leopardiana impronta, continua nella sua orribile opera di denigrazione e di violenza, ma finanche di colui al quale la giovane donna ha destinato tutto il suo flusso vitale, i migliori anni della sua giovinezza, la sua esistenza di tormento e di incanto, Raf. In siffatta maniera, mediante una traccia scritta che ribolle di eternità e di infinitudine, in un circuito in cui il finito pare perdersi per morire, tramontando, in una bolla di abbandono e nostalgia, la dolce protagonista si smarrisce in un intricato e tantalico groviglio di ragnatele ed ombre, sbattendo più volte il suo sensibile cuore contro una parete intessuta di edera e solitudine, perché, come affermato dall’autrice nello straordinario ed intenso capitolo: “Nella tempesta partorì una pietra”, “Nel dolore più atroce si rimane soli”. Eppure la nascita di una nuova vita, quella di Mia, consente a Mary di oltrepassare quella coltre di “cicatrici e baionette”, aprendosi al coraggio di vivere malgrado tutto, nonostante ogni cosa. Una fresca aurora capace di annientare le grida di quella “malattia mortale” che il filosofo danese Soren Kierkegaard definiva come paralisi capace di annichilire l’essere senza mai ultimarlo definitivamente. Quell’angoscia di esistere che si profila come vertigine di una libertà di scelta la quale irrompe prepotentemente, come diafano tepore, in una coscienza che ha sperimentato il chiaroscuro del silenzio intanto che: “Uno starnuto smuoveva un afrore acido di pioggia e di spezie esotiche, ignote”. E tuttavia: “Compagna nascosto nella condizione del mondo” fu la tenerezza, quell’affezione sprigionata da occhi vivaci e sfavillanti, quelli che risuonano da allegra gesta, da risolini beati, da quella pelle candida e profumata che accarezza, leggiadra, i tonfi di ciascuna ora. In quegli sguardi di beatitudine e di felice estasi Mary riesce a ritrovare il significato dei suoi giorni, quella forza volta a sterminare i proiettili orribili della vendetta, della prepotenza, della tracotanza di chi si nutre di una lacrima per tentare di colmare il vuoto che sorge dall’assenza di intelletto e di pensiero. Quella ragione che dovrebbe circondare, con la propria chiarezza e distinzione, le vie irrisolte dell’umana specie ma che, più volte, è eclissata dal turbamento di un folle gesto, quello del “guardare contro” il volto di chi riluce di brillantezza e candore. In tal modo, la triste vicenda di Mary sembra rievocare in fondo il destino di quegli uomini giusti che fioriscono alle pendici di una collina che si erge su un oceano di indifferenza ed apatia. Così dinnanzi ad una volta tinteggiata di stelle: “L’anima si lascia calpestare…davanti ai nostri occhi il silenzio costruisce sottili ponti […] Una parola schiusa. Un cenno appena, la lingua confusa, nell’impegno delle mani, ultimi custodi del sacro”, Mary si reca alla ricerca degli astri, imbattendosi in catene e prigioni. E ciononostante: “L’amore le apre l’anima, aumentandole il respiro, […] iridata piuma. Leggera e scalza. Tantissimi fiori, in una corona di luce, accompagnano il suo pellegrinaggio doloroso […], le ossa irrigidite dall’inverno, il dogma crudele del buio, carnivoro e più feroce di molto dell’inferno. […] Muti i gesti come nubi vuote, giace nei suoi occhi un verso fattosi più terso e lucente, scritto col sangue”. Una morte abbozzata su un giaciglio traboccante di amore e di vita. Nell’epilogo un nuovo inizio, nella fine la vera esistenza.
Chiara Ortuso

nella foto Chiara Ortuso
Najada. J. B


 English
English 日本語
日本語 中文(简体)
中文(简体) 中文(繁體)
中文(繁體) 한국어
한국어 Italiano
Italiano español
español Deutsch
Deutsch Русский
Русский